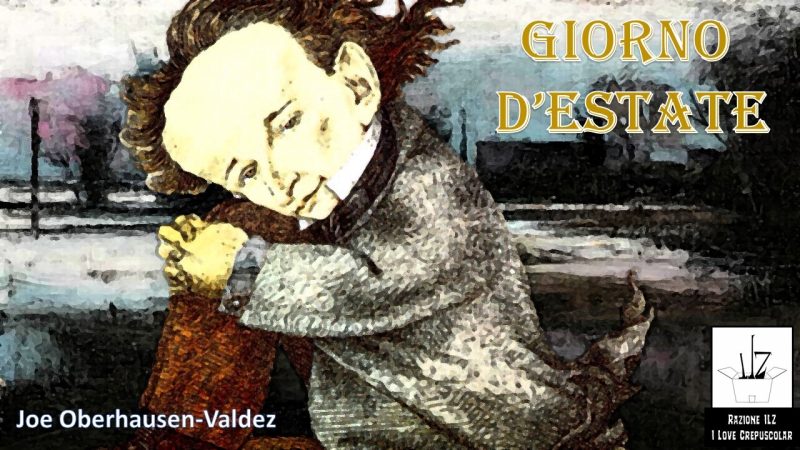L’arsura della stufa celeste, prodigiosa, vivificatrice, la stella madre di noi bachi irrilevanti, arroventava l’aria fin dalle prime ore del mattino. I miei occhi erano concentrati a leggere un libro soporifero, poggiato sul tavolino di un color verde bosco, lo stesso che splende ancora nella sua grazia di ferro qui nel giardino delle mimose.
L’autore era mediocre e persino lagnoso, a tal punto che emasculava ogni tentativo di proseguire nella lettura: appisolava e anestetizzava. D’un tratto uno dei gatti, quello grigio striato – ne avevamo una ventina in giardino – che io chiamavo Tigretto, mi portò quel che secondo lui era il tributo di caccia dovuto a me che lo sfamavo e accudivo. Ossia mezzo geco, dall’addome alla coda, giaceva, anzi si muoveva, su quel volume già amorfo, che almeno ora secerneva un liquido quasi vitale, fetente e colloso. In un attimo le mie mani librarono nell’aria, oltre l’aiuola, il libro, felino, tavolino e il mezzo geco appresso.
Mio padre uscì dallo studio, attiguo al verziere, rimproverandomi di baloccarmi insieme ai gatti invece di studiare e impegnarmi in quello che, secondo lui, era l’unico scopo o intento della vita.
Io già allora non avevo ambizioni, mire, aspirazioni, desideri e altri sinonimi similari in cui affogare il mio sangue, in altre parole: in un ammollo che mi avrebbe essiccato alla fiamma di obiettivi incerti e ipotetici, scaraventandomi in un divenire che per me era una concezione che iniziava e terminava solo nell’attimo transitorio del giorno che apre e chiude tutto.
Affanni agognati come parvenza di un fato lontano, indubbiamente astratto e inafferrabile. Foggiare oggi, letargicamente, una struttura che si sarebbe elevata al cielo fra venti o trent’anni, per essere poi già vecchia e inutile, anzi obsoleta.
Io, invece, concepivo e gustavo l’arsione della vitalità nel palpito fuggente, ammiravo il cielo cilestrino solo nella dilettazione sublime momentanea, e precisamente nell’attesa dell’avvenimento imminente: un’esaltazione fatua e scriteriata, chiara albagia giovanile, farneticante come ora.
Non presentivo ancora l’odore e la suggestione della morte, che riesuma il passato come argine alla disperazione dell’ineluttabile trapasso.
Poi tutto volse nel tempo, dal bello al vero, dal sublime all’amore, gli studi vasti e confortanti, chiostra oscura e romita; dal diletto alla solitudine, e quindi l’audace scorgere del gaudio, il sorgere del suo respiro, al di là dei colli, oltre il profumo del giardino, ormai obliato e sperso.
La Natura mi aveva fornito di un acume prodigioso, che spesso alterava la visione dell’ordinario, variandolo secondo la percezione momentanea, mutandolo in magnifico, o peggio in orrido. Esaltavo e ingigantivo il veneficio della caducità dello scorrere dell’illusione chiamata gioia, come se fosse indissolubile, allorché si appressava la bellezza di una delizia, quasi riverberando un’estasi assoluta, che presto sarebbe tramontata nella disillusione di un sipario senza scampo.
Calava il sole, quando gli occhi grifagni scrutarono una melodia mirifica, divampando nel piacere, percependo, attenti, che un refolo muoveva la grazia della sua voce fresca e limpida come una sorgiva verso me che l’osservavo o l’attendevo.
Odorava di amore e innocenza, vaga rimemorazione che non leniva quel che poi avrei penato, quando un giorno quei suoni, deliziosi e fini, si sarebbero spersi nel fosco delle ricordanze. Le memorie che annichiliscono ogni piacere passato, ogni diletto che scompare.
Il silenzio più rumoroso ormai si sovrapponeva all’accordo armonico di quel godere o patire che rivivevo in lampi lancinanti, che mi abbattevano sempre più nel corpo già prostrato e avvilito dalla decadenza inesorabile e implacabile, che attanaglia e stritola, addolora e consuma.
Vedevo un veloce sfiorire, niente più brillava in me, se non lo strazio e la desolazione di un celebrare, di un costante riesumare una stagione fittizia, distante e perduta, senza alcuna possibilità di riviverla, riassaporandone i sapori, la spensieratezza, i sogni e la meraviglia dell’aprire gli occhi a una nuova giornata.
La luce iniziava a retrocedere, s’infiacchiva e quasi scompariva, eclissandosi sotto il velo senile del malessere, che ben presto sarebbe diventato malattia e poi strazio e fine, e nient’altro più, l’ultima soglia.
Dopo aver riletto di tutto questo pessimismo, di una cupezza cosmica, un dolore infinito, uno scritto deprimente, che corrode l’anima e pure il cuore, l’amata che muore, l’inutilità della vita, piena di sofferenze e malessere, uno normale si tirerebbe una fucilata in testa.
Eppure il rimedio ai tormenti, alla disperazione, all’angoscia del “tutto cessa” era semplice.
Il fuoco che mi ardeva, che mi appassionava, o che mi abbatteva e mi avviliva, ero io, nella mia continua ecpirosi, ero io che ritornavo ancora radioso, ancora sognante. Eppure, allora tutto era infinito, muto e immobile. Era raggiante e fulgente, come ogni immensità.
Joe Oberhausen-Valdez