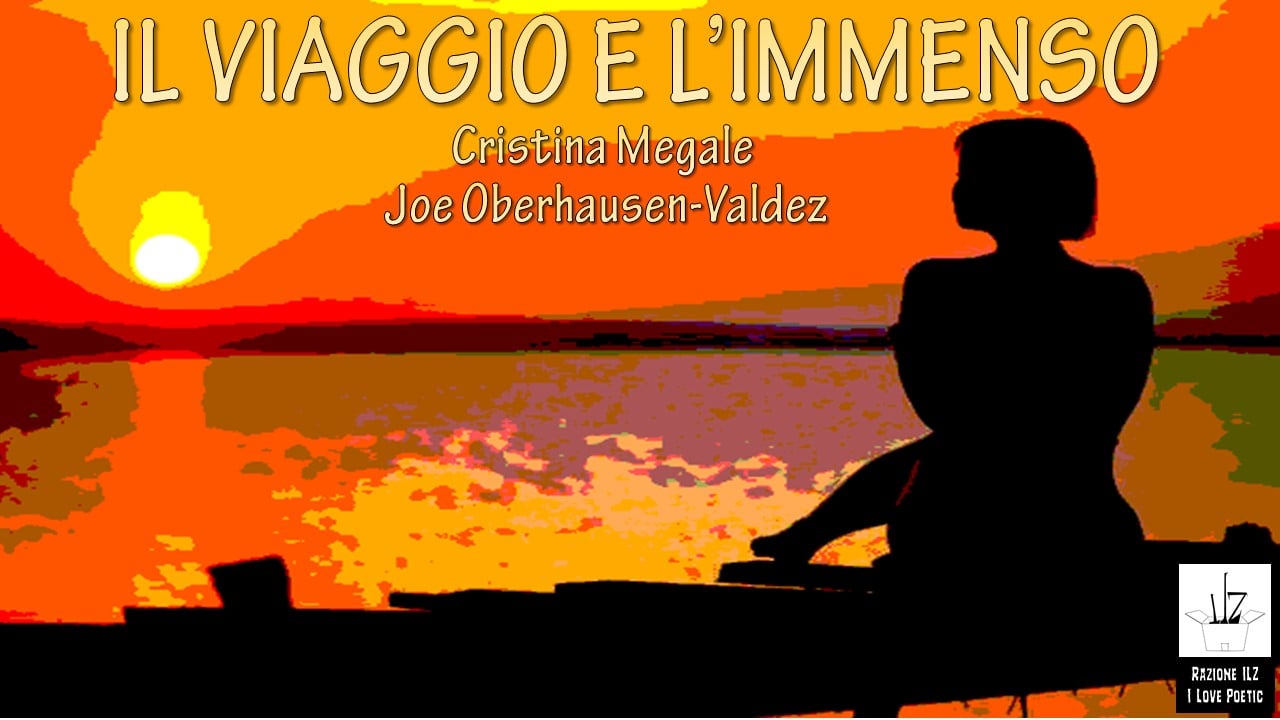Guardavo il mare e non mi stancavo mai, lo ascoltavo e mi ci specchiavo, perché era l’infinito di cui ero fatta. Era il riflesso di un animo che vagava tra scelte ardite, sorrisi e addii coraggiosi, sussurrati a fil di voce a chi e a quello che lasciavo, tra l’odore degli aranci e quello di salsedine, tra l’ocra e il bianco, tra l’azzurro del cielo e il dorato del sole, immersa nella spuma biancastra di onde rumoreggianti e loquenti.
E ci vuole sempre coraggio per partire, perché sai che poi vuoi ritornare, e quell’attimo lo vivi come se fosse un respiro che ammutolisce, attanaglia e quasi implode con un desiderio di pianto che in fondo speri di far conflagrare in gocce che irrigano gli occhi e straripano giù per il viso.
Ma poi ti arresti, ti incateni il petto, e sorridi ancora più di prima.
Cercavi te stessa, errabonda e intensa, senza mai fermarti in quei sentieri che già conoscevi e percorrevi per trovare altre vie che conducono chissà dove, in cerca di qualcosa di sfuggente e inafferrabile, un luogo effimero che non ha una meta fissa, se non sfumata, come quel punto in cui cielo e mare s’incontrano.
E in quell’orizzonte forse mi sarei fermata, per circondarmi di nuvole e di vento, al solo scopo di riflettere sull’importanza del sostare, un punto fisico oppure espressamente mentale, in un mondo che ci sbrana con la fretta, la produttività, l’ansia, la costrizione di costruire una piramide sempre più alta, schiavi e succubi di un cosmo logorante, che ci stritola come granelli miserrimi.
Ed ecco che laggiù intravedo la pausa, il ristoro, un lampo fermo, attorniata, abbracciata e persa nel blu di un tempo che non ha mai fine. Inseguendo bolle di sapone.
E infine attendo e sorrido.
Cos’è il sorriso? Forse una forma di disperazione superata o il tentativo di arginare un dolore che nasce da un vuoto arcano, che spinge alla ricerca affannosa di nuovi volti, costumi esotici, spazi e montagne silenti, in cui gli almanaccamenti dell’animo si disperdono e fluiscono tra fiumi sconosciuti, albe ristoratrici, riti inusuali, quasi primordiali, che riportano a un substrato più umano, ossia vero, semplicemente animalesco?! Un’esplorazione nell’ignoto, sitibonda di sotterranei e rovine, oscure e inaccessibili, remote e impossibili. Una congettura temporale.
Tutto ciò che non sono.
Ma se fossi vuota… perché se uno è vuoto, ovunque andrà porterà con sé solo il nulla. E il nulla non può essere riempito, se non di nulla.
Talvolta mi scoravo, in certi casi mi accoravo, travedendo illanguidita e smarrita un senso di deliquio, una vertigine irrazionale.
Ma poi la mente torna ancora aulente e ferma. E ridona calore a quello che all’esterno espando.
Ho pur sempre un nido laggiù, anche io rapace e fiera. Anche se un giorno mia madre mi disse: “vai aquila mia!”.
Un cratere in cui sciogliersi e dissiparsi, dal quale ritornare con una convinzione suprema: rientro a casa, come un drago che ha sempre bisogno del silenzio della sua caverna, respiro placido ed esclusivo, in attesa di un ulteriore sorvolo di distese e distacchi, in cui arrazzare con brividi rinnovati.
Io resto sempre mare e luce, cosparsa di profumo di renella, assetata di quell’atavico caffè mattutino, in una stanza in cui suonava la melodia di un pianoforte, che ero io, in simbiosi con la terra e i sogni, simboli indissolubili e perenni del buio del ricordo, o della mia rinascita. L’ancora a cui sempre pensare. Il mondo per sempre da amare.
Ho sempre ancor oggi gli occhi color miele tigrati spalancati su palazzi tanto alti da sfidare quasi la maestosità del cielo.
Fu questo il mio primo incontro con quella che oggi è la mia città d’adozione: terra che mi ha accolta, e in cui sono rinata in un giorno di primavera.
Ribelle come i miei ricci che scendono indisciplinati lungo la schiena, arrivai qui, dove la Madunina svetta sopra i tetti e la musica suona fino a tarda notte. Ho incatenato il cuore, tenuto stretto per mano il coraggio e mosso il primo passo verso quella donna errabonda senza catene vestita di sorriso. E bla bla bla.
Tutto questo mi disse, forse neanche parlando. Ed io che potevo fare o recepire?!
Il luccicare di quegli occhi striati, variegati, felini, sublimi e chiari; il suo “semisorriso”, più di tutto inebriante, eclissava triste triste il viso che racchiudeva un tormento che a tratti rivestiva di una posa trasfigurante, al di fuori di un sussulto che risiede sempre celato.
Era immota e inalterabile, quasi di foggia plastica, quando volgeva lo sguardo in quell’infinito che lei portava dentro. E tutto in me colpiva e tutto in me trafiggeva.
Una potenza in sé (e fuori di sé) che probabilmente conosceva, malamente disciplinava, e non spesso controllava. La percepivo a priori, d’impatto, e quindi proseguivo e mi arrestavo, e poi ne venivo travolto, forse non comprendendo, forse non potendo arginarla o apprenderla.
Non avevo mai avuto uno scopo, descrivevo solo ciò che mi piaceva, che mi appariva sublime, quel che si intrufolava per incanto, per caso, a volte come un caos.
La meraviglia improvvisa e limpida.
Immortalavo fotogrammi, desideravo svilupparli, quasi per far divenire l’istinto, lo sconosciuto e ciò che è lontano – parvenza impossibile – un sogno rileggibile o reinterpretabile.
È sempre quel qualcosa che mi riempie l’anima, vaporosa e onirica, un non so che… un attimo che evade, sparisce, che vorrei imprigionare, affinché non se ne rivoli via come aquila, o sorriso che sia. Un attimo che è l’Infinito, che rallenta l’animo con la sua velocità o lentezza, lo ferma tra le mani, e poi tutto giustifica assolve e forse inganna.
L’attimo è sempre una trappola carezzevole e leziosa. Ci cadi dentro perché sai che è attraente, magnifica. Sai che è fatale.
E non vorresti che fosse stata concepita diversamente.
L’estate volgeva verso il cambiamento, variazione e rinnovamento, che tutto sommato non è poi così triste, noioso e dispersivo. È il tempo in cui ci si ridesta, tra l’albeggiare posticipato e il crepuscolo che sovviene ancor prima di quanto non si creda.
La luce del giorno cede il passo al cielo grigio traboccante di cirri, e poi di cumuli carichi di pioggia che invadono le strade, bagnano i vetri delle finestre, e già dimentichi il caldo di quel mare lontano, la finestra da cui ti affacciavi, la “Vespa” bianca ferma al sole del meridione, la vecchietta che guardava i flutti dall’inferriata di un balcone arrugginito di una casa diroccata, ma ancora viva.
Lontane le immersioni tra le rocce screziate di verde, lontane le pose alla scogliera, accecata dal sole o dal lampo di una macchina da presa, immortalata con un cappello a tese larghe nel sorriso di un bagliore che era immenso. L’Immensità.
Era ebbrezza euforica, era il fragore della gioia.
E ora qui è tutto silenzioso. Diverso, passato, incerto.
Il rumore non è il suono delle onde, ma lo stridere di ferro sull’acciaio, il trambusto di un alveare che rimbomba con cigolii che potrebbero essere creduti trilli, o armonie, per chi li ha appresi fin dagli arbori della propria culla.
Riappare il desiderio dell’eterno ritorno a quel mondo, che era il suo mondo, il sorriso di cui è fatta, nel suo sostrato e nella sua apparenza.
Ma l’estasi non ha mai un tempo e neanche un luogo.
La ricordavo ancora immersa tra i ripiani di innumerevoli scarpe, in un negozio qualsiasi di un’isola qualsiasi, lontana e irraggiungibile.
Eppure ora è lì, coi capelli ondulati che guarda fuori verso il cielo, attraverso le grandi vetrate di una città diversa, in un tempo distante e dissimile, seduta su una sedia bluastra su cui campeggia la scritta J.K. Rowling.
Si volta due o tre volte a destra verso la porta d’ingresso, pensierosa e cupa. Infine spalanca le iridi venate tutte tutte color del suo mare, distende le gote, finalmente ride, e poi…
E poi, farà male all’inizio. Ma dopo sarà un’insignificante cicatrice e nulla di più.
voltati e sorridi.
Cristina Megale
Joe Oberhausen-Valdez