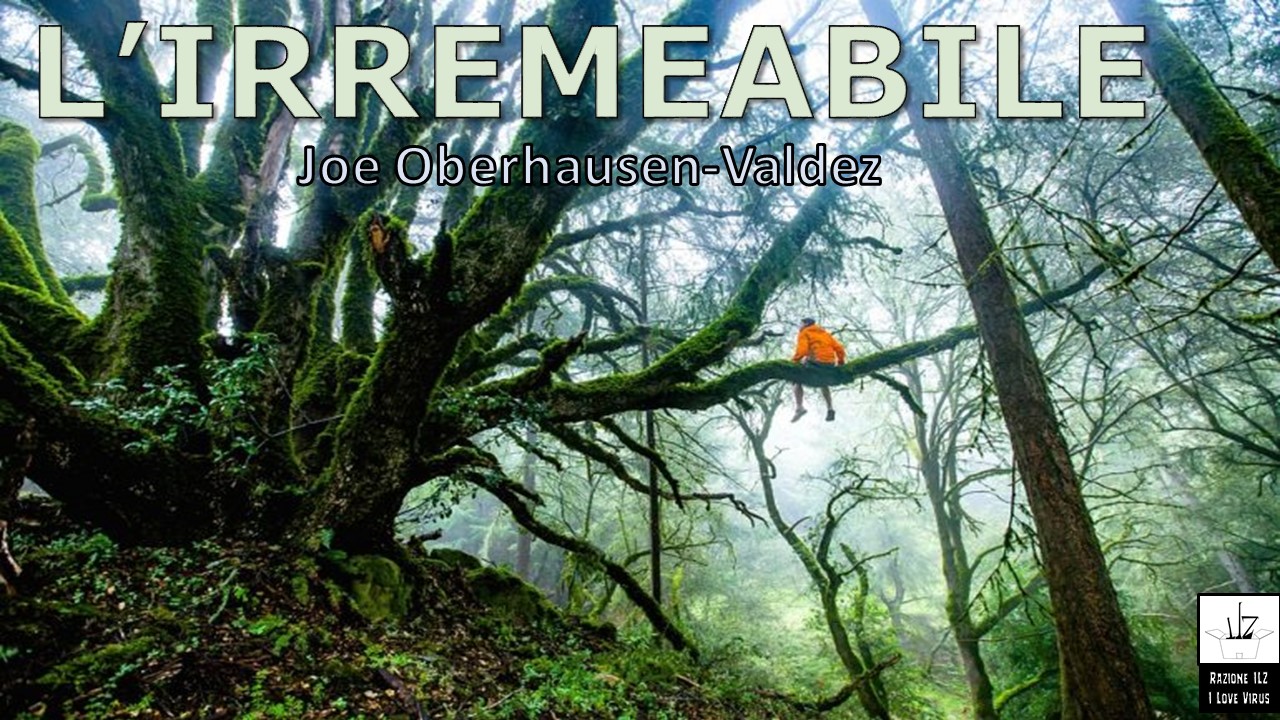Mi affacciai sul balcone, guardando la strada, cercando di scorgere un rumore, qualcosa che fosse vivo, a parte un uccellaccio che gracchiava nascosto sul ramo di uno dei tre pini.
Ma non si udiva niente.
Non era una semplice influenza, non era un virus, probabilmente era un’arma batteriologica creata dalla Natura per sbarazzarsi il prima possibile dell’uomo, che ormai stava distruggendo il creato con la sua follia nichilista, con lo sfruttamento esasperato del mondo, uccidendo animali di ogni sorta, abbattendo innumerevoli foreste, depredando e inquinando i mari. Ossia, ci stavamo annientando da soli.
La Terra stava soffrendo e non capiva, e non capimmo neanche noi all’inizio, tranne quando la pandemia divenne un evento irremeabile. E infatti non avremmo più potuto arginare l’ecatombe.
Il nuovo anno per me cominciò male, con una gastrite che mi impedì di mangiare come avrei voluto, strafogandomi di leccornie, dolciumi, liquori e altre prelibatezze nocive.
Il mio stomaco era una fogna e io ingurgitavo bocconi, maledetti per il corpo, come una cloaca, e presto ne avrei pagato le conseguenze con quel dolore e con interminabili reflussi gastroesofagei. Ma dopo una cura serrata, il periodo di sofferenza passò e mi ripresi.
Stava per arrivare la primavera, la vedevo dagli alberi da frutta che iniziavano a fiorire, la respiravo nell’aria, la ricevevo dal calore del mio sole che diveniva ardente come in ogni bella stagione. Risplendeva il verde del prato rugiadoso con un luccichio tipico dell’alba che in quel momento schiariva l’ombra della notte.
Di fronte a me, guardando la vigna, buttavo gli occhi oltre tutti i terreni che mi separavano dallo Jonio, distante solo una decina di chilometri dalla mia casa in linea d’aria, o forse meno. Laggiù la luce baciava l’interminabile distesa d’acqua che si univa al cielo in una delimitazione di confine che non potevo distinguere. Terra, cielo e mare non avevano una separazione.
La notizia del virus si sparse lentamente, per poi divenire assillante giorno per giorno. Si era propagato da un posto in cui non sarei mai andato. Laggiù vi abitavano esseri che mangiavano i cani.
La gente si ammalò di un’influenza che sembrava inarrestabile e incurabile, contagiando ben presto i paesi limitrofi e poi tutto il globo, finché non fu dichiarata la pandemia.
Eppure gli uomini ne sottovalutavano la portata e il maleficio, pensando che si trattasse di una malattia contenibile, passeggera e di poca rilevanza.
Continuavano ad andare a lavorare negli uffici, non prestavano attenzione ai moniti dei medici, pensavano che la vita non sarebbe mutata, che avrebbero continuato a godere le ferie estive al mare, seguendo le scadenze di una società che ottenebra, annichilisce e riduce l’anima a un calcolatore sterile e obsoleto. Erano macchine senzienti, vuote di sogni e mancanti di acume.
Non temevano il mostro apparso silenzioso e funesto, che presto avrebbe decimato senza distinzione di razza, di età, che avrebbe tracannato gli uomini come un pozzo nero.
Io spesso avvertivo gli amici e i parenti di prendersi una vacanza, di astenersi da ogni passeggiata, di stare a casa, di non uscire per nessun motivo. A casa ora! Perché non sarebbero arrivati all’estate, e neanche alla primavera.
Ma loro non capivano, erano ottusi, erano ormai plasmati ad asservire uno stile di vita ripetuto, asettico. Una vita da castrati.
Si alzavano ancora la mattina presto, per recarsi in ufficio; temevano il disastro dell’economia, la catastrofe della recessione, la scadenza della rata del mutuo, l’incubo delle banche e delle riscossioni dell’Agenzia dell’entrate; cercavano un bar aperto per prendere il caffè, si affannavano alla ricerca della normalità, invece di barricarsi dentro le mura della propria tana.
Poveri idioti… non capivano che quel mondo era compromesso, era finito già ieri.
Adesso l’unico scopo dell’uomo — e mai ce ne fu altro — era mangiare, e sopravvivere, facendo scorte di cibo, di beni necessari, di strumenti utili nella disperazione, aspettando che la terra inghiottisse il virus, che non era la malattia ma l’uomo assuefatto alla normalità, drogato della sua mediocrità, dispensatore di morte programmata, costruttore di macelli in cui gli animali muoiono tra sofferenze ineluttabili. L’uomo, che si pasce di spettacoli cruenti come la corrida, per saziare la sua fame di crudeltà, inebriandosi gli occhi di sangue.
L’umo cancro del pianeta.
I vari governi diedero direttive, presero precauzioni, imposero piani di emergenza, che non servirono a nulla. Si doveva restare a casa, o si doveva morire. Non c’era altra scelta che aspettare il proprio destino, rintanati come predatori in attesa di giorni migliori.
E io così feci, come nella mia indole previdente, che da lungo tempo aveva scelto l’autarchia e l’isolamento.
Quando non era ancora stata dichiarata la pandemia, iniziai a riempire la camera estiva di mia madre, che abitava in un altro paese, di viveri, bevande, croccantini per i miei cani. Saremmo sopravvissuti per mesi, senza infettarci, non contagiando nessuno, giacché nessuno sarebbe entrato e uscito dalla mia casa, soprattutto io. A meno che il virus, o l’arma batteriologica, non si diffondesse pure respirando l’aria del vasto giardino.
Il settanta per cento della popolazione mondiale si era ammalato. La televisione comunicava gli innumerevoli decessi, le poche guarigioni, gli ospedali ormai saturi di cadaveri e di ricoverati inguaribili.
Ben presto la morte avanzò senza por tempo in mezzo, abbracciò il creato, lasciando in vita solo una vaga percentuale di uomini, risparmiando gli animali che erano immuni fin dall’inizio da ogni contagio, immuni alla vendetta della Natura perché esseri puri.
E di colpo mi ritrovai in pieno medioevo, senza elettricità, senza aerei che inquinano l’aria, senza televisione, senza mutuo da pagare.
Quel giorno era finito il progresso, l’evoluzione si arrestava, e meno male; pochi uomini avevano compreso che si trattava davvero di un’apocalisse, che avrebbe azzerato gli errori di una divinità o del Caso. Quel caos sarebbe stato una nuova era, migliore, genuina, la fine dell’arroganza dell’uomo come padrone e predone di un mondo in cui siamo solo ospiti, indesiderati e perniciosi.
Questo sconvolgimento era il pianto versato da migliaia di anni da tutti coloro che, dotati di un’anima, soffrivano e invocavano pietà. L’uomo non ne aveva.
E neanche la Natura ne ebbe.
Estate 2020
E quindi allora mi avvidi che era finalmente primavera.
L’odore dei pini e delle margherite mi inebriava, il ciliegio fioriva, il silenzio della strada era un’estasi. Le piante dell’orto crescevano e si innalzavano al cielo in un effluvio di colori.
Ascoltavo il suono delle fronde mosse da un lieve vento, guardando una lepre che correva gioiosa tra le ginestre del boschetto sotto il giardino, riscaldandomi ad un sole che appariva sempre più abbagliante e immenso.
Ora assaporavo davvero la serenità del vivere senza meta, senza finalità. Fermo a contemplare l’eternità di una stagione che non ha ansie, mire, desideri.
Una vita priva di ambizioni e logorii, una vita che travalica terre, attese, speranze e disillusioni.
Quel mondo, il mio mondo, non sarebbe mai terminato.
— Perché?
Perché nella mia esistenza non era mai mutato niente.
Joe Oberhausen-Valdez